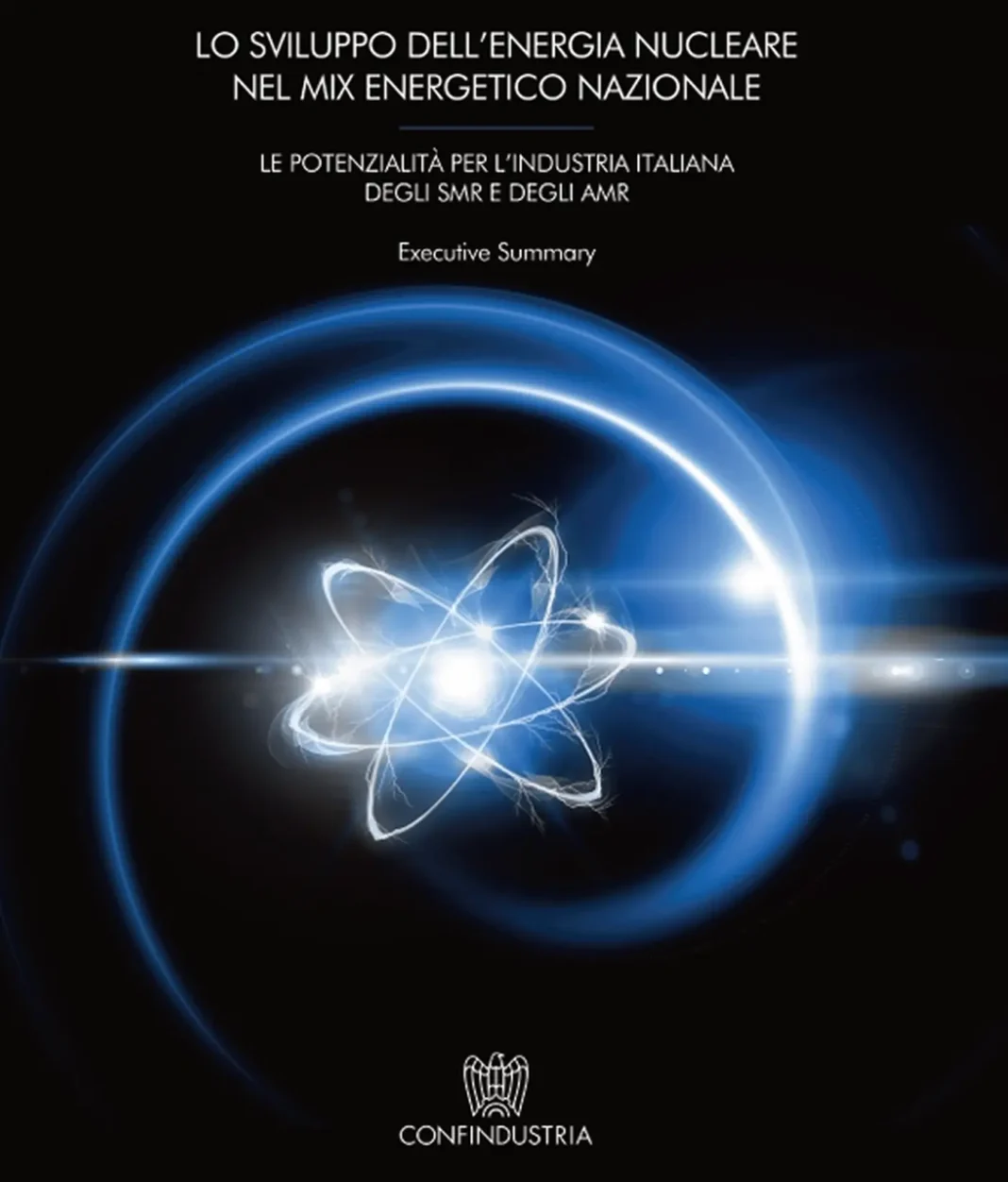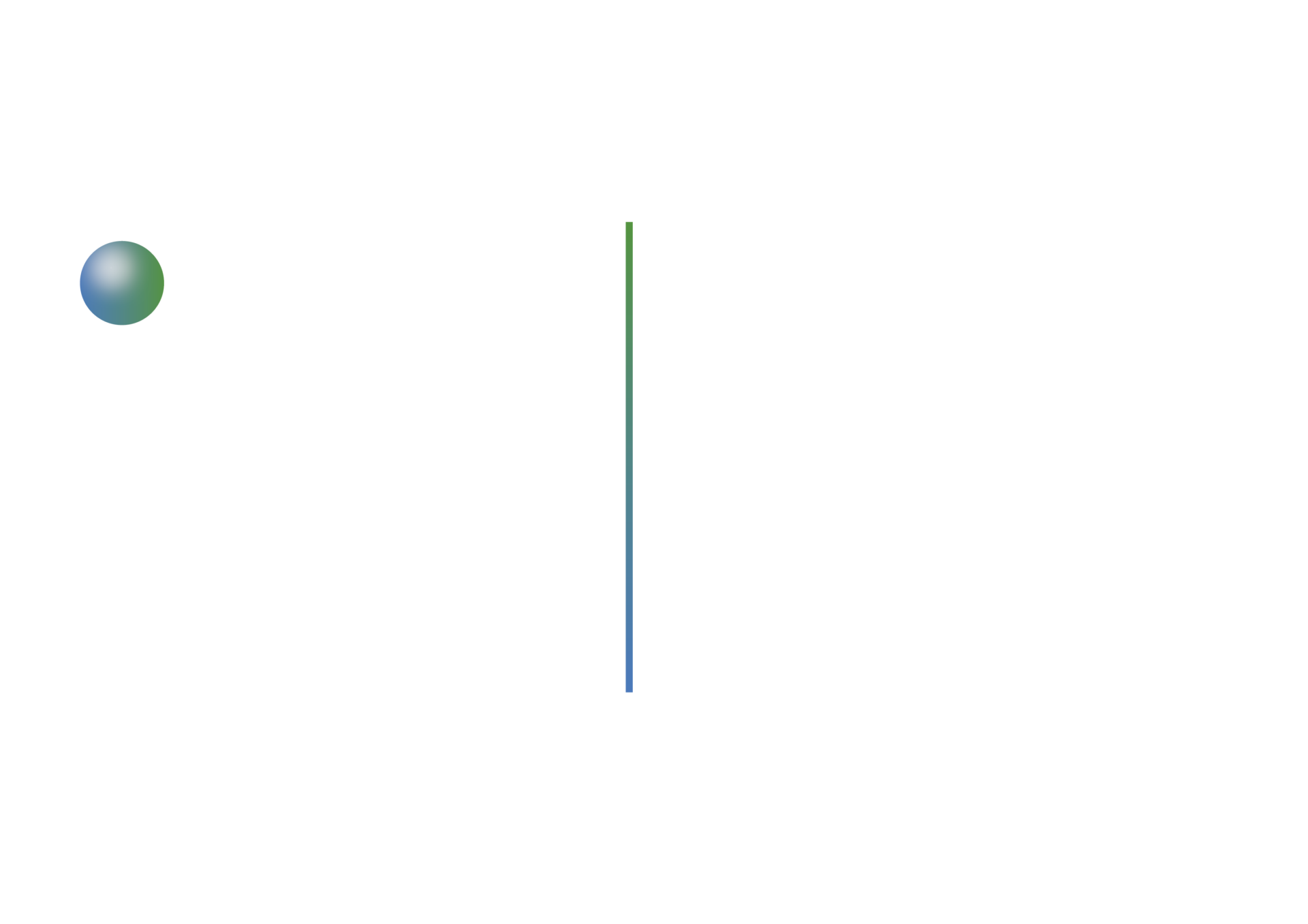ENEA e Confindustria hanno presentato il nuovo rapporto “Lo sviluppo dell’energia nucleare nel mix energetico nazionale – Le potenzialità per l’industria italiana”, un documento (scarica) che traccia la strategia per reintrodurre il nucleare nel panorama energetico del Paese, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza dell’approvvigionamento e competitività dell’industria italiana.
Leggi anche: L’Italia entra nell’Alleanza Europea del Nucleare.
Secondo Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’energia, il valore complessivo della filiera nucleare italiana potrebbe arrivare a 46 miliardi di euro, generando 15 miliardi di valore aggiunto diretto e un impatto economico annuo superiore ai 50 miliardi, pari a circa il 2,5% del PIL nazionale.
Tale programma attiverebbe fino a 120.000 nuovi posti di lavoro in totale (117.000 secondo lo scenario PNIEC) di cui circa 39.000 diretti nella filiera, a fronte dei 13.500 occupati odierni.
Secondo gli scenari analizzati, con un primo impianto operativo dal 2035, il nucleare risulterà vantaggioso sia dal punto di vista economico che energetico, con benefici di rilievo per l’industria, soprattutto per i processi ad alta temperatura difficili da decarbonizzare.
Policy, quadro normativo e governance istituzionale
Il programma necessiterà di una determinazione politica di lungo termine e, pertanto, di ampio respiro.
L’adozione di misure europee come l’Electricity Market Design Regulation, il Complementary Climate Regulation e il Net-Zero Industry Act (NZIA), che riconoscono il nucleare come tecnologia strategica per la decarbonizzazione, rappresenta un passo cruciale per accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni.
Questi strumenti favoriscono l’integrazione del nucleare tra le tecnologie prioritarie per la sicurezza energetica e la competitività industriale, incentivando investimenti, innovazione e sviluppo delle filiere nazionali.
Per ridurre i tempi di implementazione del programma sarà fondamentale predisporre un assetto normativo snello, che si appoggi su accordi internazionali e sui più elevati standard di sicurezza e protezione dalle radiazioni promossi dall’Unione Europea e dagli stati membri.
Parallelamente occorrerà istituire anche un’Autorità di sicurezza nucleare competente e dotata di un’effettiva indipendenza nei processi decisionali e regolatori.
Dulcis in fundo, ma non per importanza, è la creazione della cabina di regia per mezzo della quale possano essere coordinate e sincronizzate tutte le azioni che i diversi attori dovranno attuare, inclusi i ministeri e organizzazioni nazionali.
La cabina di regia dovrà inoltre assicurare la continua collaborazione tra gli stakeholder nazionali, coinvolti o interessati nel programma nucleare.
Da quali tecnologie ripartire?
Secondo il rapporto di ENEA e Confindustria, “sempre più Paesi stanno considerando un massiccio ricorso al nucleare per poter traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione, indicando come obiettivo la triplicazione della capacità attualmente installata”.
Il rilancio del programma nucleare italiano si fonderebbe sull’impiego delle tecnologie più moderne e avanzate disponibili, tra cui i reattori di terza generazione avanzata (III+), quelli di quarta generazione (IV) e le soluzioni modulari di piccola taglia come gli SMR (Small Modular Reactor) e gli AMR (Advanced Modular Reactor).
Come quelli già esistenti questi tipi di impianti offrono tutti i vantaggi e pregi del nucleare:
- Emissioni climalteranti minime durante l’intero ciclo di vita;
- Produzione programmabile e stabile di elettricità e calore in modalità cogenerativa;
- Minime necessità di combustibile (consentendo di stoccare facilmente riserve strategiche) e produzione di rifiuti;
- Costo dell’energia marginalmente influenzato dal costo del combustibile, dunque stabile e garantito;
- Maggiore stabilità, sicurezza e affidabilità della rete elettrica, senza costi aggiuntivi per il sistema di distribuzione.
Al fianco delle rinnovabili, il nucleare consentirebbe di stabilizzare e irrobustire la rete elettrica, avvicinando la produzione ai grandi centri di consumo e riducendo il consumo di suolo.
Il comparto industriale potrebbe trarre vantaggi significativi dal rilancio del nucleare, considerando che oggi rappresenta il principale consumatore di energia elettrica in Italia, con quasi il 40% dei consumi nazionali.
A ciò si aggiunge l’elevata domanda di calore generato in cogenerazione e un ampio ricorso al gas naturale (destinato, in prospettiva, a essere sostituito anche dall’idrogeno) per la produzione diretta di calore.
Numerosi processi produttivi ad alta intensità energetica, in particolare quelli cosiddetti “hard to abate”, richiedono infatti temperature molto elevate, difficili da ottenere con le attuali tecnologie basate sulle fonti rinnovabili.
Gli aspetti economici
La struttura dei costi dell’energia nucleare è fortemente concentrata nella fase di costruzione dell’impianto, mentre le componenti operative (gestione e combustibile) incidono in modo marginale.
Questo rende il costo di produzione estremamente stabile, meno soggetto alla volatilità del mercato delle materie prime.
Tale stabilità rappresenta un pilastro strategico per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e sostenere la crescita del sistema produttivo industriale nazionale.
Puntare su progetti capaci di valorizzare modularizzazione e standardizzazione degli impianti, con investimenti multinazionali, permetterà di sfruttare l’economia di serie e contenere i costi.
Secondo la IEA, entro il 2050 l’investimento iniziale per SMR e AMR sarà tra i 3.000 e i 5.000 USD/kW, con un costo di generazione tra 70 e 110 USD/MWh, competitivo rispetto ad altre tecnologie.
Stabilità dei prezzi, programmabilità e competitività richiedono un sostegno pubblico articolato in tre fasi, con incentivi mirati e tempestivi per garantire il successo del nucleare nel mix energetico:
- Fase 1: Costituzione di partnership con vendor e attori multinazionali, per il posizionamento strategico della supply chain italiana, agevolato da finanziamenti per lo sviluppo delle capacità dell’industria e della ricerca a contribuire già nelle fasi di sviluppo del progetto;
- Fase 2: Realizzazione dei primi impianti in Italia, con il pieno coinvolgimento della supply chain nazionale, fornendo supporto ai soggetti che concorrono alla realizzazione di tali impianti, al tessuto industriale per colmare lacune e rinforzare la capacità produttiva, e agli utenti finali perché possano più agevolmente approntarsi a beneficiare del calore di processo fornito in cogenerazione dagli impianti;
- Fase 3: Ampliamento del parco reattori, supportando la diffusione della tecnologia per aiutare le utility nella gestione del rischio, e continuando ad agevolare gli utenti finali nell’adozione di soluzioni per l’adeguamento dei processi industriali finalizzato a promuovere l’utilizzo di calore e idrogeno di produzione nucleare, a beneficio di una più vasta decarbonizzazione.
Comunicazione, formazione e sostegno alla ricerca
È urgente definire un piano nazionale per la qualificazione di tecnici e professionisti, coinvolgendo università, istituti tecnici, enti di ricerca e aziende su diversi ambiti disciplinari (ingegneria, fisica, chimica, giurisprudenza, management), con percorsi di formazione e addestramento sul campo, anche per profili provenienti da altri settori.
Per restare competitivi a livello globale, è fondamentale il sostegno pubblico alla ricerca, che consenta di aumentare gli investimenti e rafforzare le infrastrutture.
Studi e sondaggi evidenziano un crescente consenso per il nucleare, ma anche una diffusa carenza di informazione. In questo contesto è necessaria una comunicazione chiara, accessibile, trasparente e basata su dati oggettivi per favorire un dibattito informato e una partecipazione attiva che preveda il coinvolgimento tutte le parti interessate e la diffusione di una narrativa corretta con la quale fornire le conoscenze base che consentano al pubblico di avvicinarsi con maggiore consapevolezza alle riflessioni e ai dibattiti.
La filiera industriale italiana
Sono oltre 70 le aziende italiane che oggi continuano a operare nel settore nucleare, offrendo competenze avanzate sul mercato europeo e internazionale e ottenendo nuove commesse per impianti a fissione e fusione.
Grazie alla collaborazione tra industria, università ed enti di ricerca, si sono preservati importanti nuclei di competenze tecnico-scientifiche, sia in ambito tecnologico che industriale.
Le imprese nazionali operano in settori chiave della filiera nucleare, come la progettazione del nocciolo e dei sistemi di sicurezza, la sperimentazione su reattori ad acqua e metalli liquidi, la produzione di grandi componenti e la gestione operativa degli impianti.
Questo patrimonio industriale e tecnico, se adeguatamente sostenuto, può rappresentare un volano per rafforzare e ampliare la filiera nazionale, abilitando concretamente la ripresa di un programma nucleare in Italia.
D’altra parte, l’ampliamento della capacità della catena del valore nazionale dovrà avvenire in modo coordinato, dando priorità a quelle aree che più necessitano di rafforzamento (o perché attualmente sguarnite, o in quanto potenzialmente limitanti della capacità complessiva del sistema), promuovendo l’integrazione tra i diversi attori, e creando condizioni – specie nel contesto internazionale – che consentano di costituire consorzi e partnership premianti per le imprese.